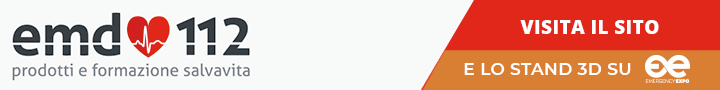Reazioni avverse da mezzo di contrasto: quali sono e quale incidenza hanno?
Il mezzo di contrasto è una sostanza utilizzata durante gli esami radiologici per migliorare la visibilità delle strutture del corpo, aumentando il contrasto fra i vari organi e tessuti
Incidenza degli effetti collaterali
Sebbene siano ritenuti sicuri, talvolta si possono verificare degli effetti collaterali ai mezzi di contrasto.
L’incidenza stimata di complicanze radiologiche attribuite alla somministrazione di mezzi di contrasto (MdC) risulta fortunatamente abbastanza bassa, con valori inferiori all’1% e con una mortalità di 1/60.000 esami.
La maggior parte delle reazioni sono idiosincrasiche e non prevedibili, ma un’attenta anamnesi potrebbe consentire di individuare alcuni fattori di rischio e permettere di impostare un piano di profilassi e di trattamento immediato efficace fin dai primi sintomi, in particolare in caso di reazione anafilattica, che altrimenti può condurre rapidamente allo shock.
Per tale motivo nel percorso diagnostico-terapeutico vanno seguiti protocolli di trattamento, ispirati alle Linee Guida, internazionalmente riconosciuti come validi per le condizioni di emergenza-urgenza.
Fra i vari mezzi di contrasto quelli più utilizzati e più spesso responsabili delle reazioni avverse sono quelli iodati, utilizzati soprattutto in ambito angiologico, urologico e ginecologico.
Attualmente, ove possibile, si utilizzano i cosiddetti mezzi di contrasto di terza generazione non ionici, molto più tollerabili rispetto quelli ionici.
Le reazioni possono insorgere immediatamente, tuttavia si possono verificare anche reazioni ritardate dopo un’ora o talvolta anche fino ad una settimana.
Quali sono i possibili effetti collaterali ai mezzi di contrasto?
Le reazioni avverse al mezzo di contrasto si suddividono in:
- Chemiotossiche (tipo A). Sono chiamate così perché la tossicità del composto è legata alla sua composizione chimica. Tali reazioni sono dipendenti dalla dose e dalla concentrazione plasmatica del farmaco, perciò potenzialmente prevedibili.
- Anafilattoidi (tipo B). Sono quelle in cui il rapporto causa-effetto è più difficile da stabilire, non dose-dipendenti e sono per definizione imprevedibili (possono indurre il rilascio di istamina o di altri mediatori solitamente attivi nei fenomeni allergici).
A seconda della loro severità le reazioni avverse al mezzo di contrasto vengono suddivise in:
- lievi: sapore metallico, sensazione di calore, nausea e vomito, sudorazione, disestesia periorale, dolore nella sede dell’iniezione, orticaria, emicrania;
- moderate: persistenza ed aumento di intensità dei sintomi minori, dispnea, ipotensione, dolore toracico;
- severe: broncospasmo, ansia, diarrea, parestesie, edema localizzato e non, dispnea, cianosi, ipotensione marcata, bradicardia, shock, edema polmonare, aritmie, convulsioni, paralisi, coma, morte.
Fattori di rischio per le reazioni avverse al mezzo di contrasto
Possono essere considerati potenzialmente a rischio:
- i soggetti con pregressa reazione nota ai mezzi di contrasto;
- i soggetti asmatici e i soggetti allergici che fanno ricorso a trattamento farmacologico continuo e periodico;
- i soggetti con allergia al lattice;
- i soggetti molto giovani o molto anziani, in tal caso è l’età del paziente il potenziale fattore di rischio;
- le donne.
Fondamentale appare l’accurata valutazione dello stato clinico del paziente: la ridotta funzionalità renale e cardiovascolare rappresentano i veri fattori di rischio.
Alla luce delle osservazioni secondo cui le reazioni più severe ai mezzi di contrasto possono essere sostenute da un meccanismo anafilattico, alcuni studi suggeriscono di sottoporre ad accurata visita allergologica tutti i pazienti con precedenti episodi di reazione avversa ai mezzi di contrasto.
Tuttavia, non esistono esami in grado di prevedere l’insorgenza di effetti secondari alla somministrazione del mezzo di contrasto.
È possibile prevenire gli effetti collaterali al mezzo di contrasto?
Gli studi sul trattamento con cortisonici e antistaminici per i pazienti a rischio di reazione avversa al mezzo di contrasto hanno evidenziato risultati discordanti.
Non esiste ad oggi alcuno studio randomizzato, nell’uomo o nell’animale, che abbia provato l’efficacia di una profilassi con antistaminici e/o corticosteroidi nel prevenire le reazioni.
È stato osservato che la premedicazione con cortisonici ed antistaminici ha ridotto l’incidenza delle reazioni avverse lievi, senza modificare l’incidenza delle reazioni più gravi.
Per i pazienti che abbiano mostrato gravi reazioni avverse è fondamentale somministrare un trattamento ad hoc nel primo minuto dalla comparsa dei sintomi.
L’utilizzo di mezzi di contrasto ipo-osmolari non ionici e della premedicazione, per quanto realizzata con procedure e modalità differenti, non hanno eliminato del tutto la probabilità di reazioni avverse.
Mezzi di contrasto e insufficienza renale
Capitolo a parte merita la nefropatia indotta da mezzi di contrasto.
I mezzi di contrasto possono causare vasocostrizione dell’arteria tubulare renale e alterazione dell’emodinamica glomerulare.
In generale, prima di somministrare un mezzo di contrasto in tutti i pazienti è necessario dosare la creatinina serica e calcolare la velocità di filtrazione glomerulare (GFR):
- Nei pazienti adeguatamente idratati e con funzionalità renale nella norma, è improbabile che si verifichi un’insufficienza renale acuta.
- Nei pazienti con lieve alterazione della funzionalità renale, l’idratazione prima della somministrazione del mezzo di contrasto di solito evita il peggioramento del quadro renale.
- Nei pazienti con alterazione renale di grado moderato-severo, bisogna invece prendere in considerazione indagini strumentali alternative.
- Nei pazienti diabetici in trattamento con metformina, è raccomandata la sospensione del farmaco almeno 12 ore prima di un esame contrastografico; questo perché la metformina è stata associata a diversi casi di insufficienza renale e acidosi lattica in pazienti esposti a mezzi di contrasto.
Pertanto, per ridurre il rischio di nefropatia indotta da mezzi di contrasto, è importante:
- Dosaggio creatinina e calcolo del GFR;
- Evitare di ripetere la somministrazione di alte dosi a brevi intervalli;
- Idratare il paziente adeguatamente per via endovenosa se necessario;
- Utilizzare mezzi di contrasto non ionici a bassa osmolarità;
- Interrompere il trattamento con ipoglicemizzanti orali almeno 12 ore prima dell’esecuzione dell’esame con mdc;
- Evitare l’uso concomitante di farmaci che possono causare vasocostrizione renale (es. FANS).
- Nella maggior parte dei casi di complicanze nefrotossiche, la funzionalità renale torna al valore basale senza uno specifico trattamento.
Mezzi di contrasto e patologie della tiroide
In caso di presenza di patologie tiroidee, la tireotossicosi indotta da mezzi di contrasto iodati è rara: lo iodio infatti non provoca alterazioni significative nei soggetti con funzionalità tiroidea normale.
I pazienti con morbo di Basedow e gozzo multi nodulare, invece, presentano un rischio superiore.
Invece i soggetti con tireotossicosi non possono sottoporsi ad esami con mezzi di contrasto iodati perché tali pazienti rischiano di sviluppare una crisi tiroidea.
Da non dimenticare, inoltre, che i mezzi di contrasto iodati possono in tutti i pazienti alterare i valori degli esami ormonali tiroidei fino ad 8 settimane successive alla somministrazione del liquido stesso.
Per approfondire
Emergency Live ancora più…live: scarica la nuova app gratuita del tuo giornale per iOS e Android
Che cos’è il clisma opaco doppio contrasto?
Radiografia: il ruolo dell’imaging nella diagnosi di ossa e tessuti molli
Il paziente lamenta crampi addominali: a quali patologie si possono associare?
Diagnosi del carcinoma prostatico
Uretrocistoscopia: che cos’è e come viene eseguita la cistoscopia transuretrale
Diagnostica: la Risonanza Magnetica Multiparametrica della Prostata (RM mp)
Cos’è e a cosa serve la Radiografia della colonna vertebrale in toto
Radiografia: che cos’è e in che cosa consiste
Che cos’è l’angio RM (angio-risonanza magnetica )?
Che cos’è la radiografia della mano (RX mano)?
Scintigrafia ossea: come si esegue
Che cos’è l’agoaspirato (o agobiopsia o biopsia)?
TAC (Tomografia Assiale Computerizzata): a che cosa serve
Risonanza Magnetica Nucleare (RMN): quando farla?
Tomografia Computerizzata ad Emissione Singola di Fotoni (SPECT): cos’è e quando si esegue
Malattie Reumatiche: il ruolo della Risonanza Magnetica Total Body nella diagnosi
Termografia medica: a cosa serve?
Tomografia ad Emissione di Positroni (PET): cos’è, come funziona e a cosa serve
Esami strumentali: cos’è l’ecocardiogramma color doppler?
Holter cardiaco, le caratteristiche dell’elettrocardiogramma delle 24 ore
Cos’è il Loop Recorder? Alla scoperta della Telemetria domiciliare
Cateterismo cardiaco, cos’è questo esame?
PET: a cosa serve e come si svolge l’esame
Diagnostica: la Risonanza Magnetica Multiparametrica della Prostata (RM mp)
Risonanza magnetica del cuore: cos’è e perché è importante?
TAC, Risonanza magnetica e PET: a cosa servono?
Uretrocistoscopia: che cos’è e come viene eseguita la cistoscopia transuretrale
Cos’è l’ecocolordoppler dei tronchi sovraortici (carotidi)?
Angioplastica carotidea e stenting: di cosa stiamo parlando?
Angioscopia percutanea: che cos’è la capillaroscopia?
Risonanza magnetica del cuore: cos’è e perché è importante?
TAC, Risonanza magnetica e PET: a cosa servono?
Risonanza Magnetica Mammaria: che cos’è e quando si fa
Mammografia: un esame ″salvavita″: in cosa consiste?
Tumore seno, l’oncologa Zuradelli (Humanitas): “Test genetici per medicina di precisione”
Che cos’è un tumore e come si forma
Mammografia: come si esegue e quando farla
Pap-Test: cos’è e quando farlo?
Tumore al seno: l’oncoplastica e le nuove tecniche chirurgiche
Cos’è la Mammografia digitale e quali vantaggi presenta
Tumore mammario: gli strumenti per una diagnosi precoce
Sangue rosso nelle feci: quando preoccuparsi?